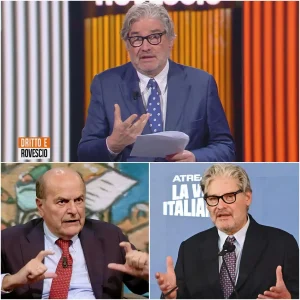Gennaio 1944, sette del mattino. La temperatura raggiungeva gli undici gradi sotto zero nel campo di prigionia di Chirmeek, eretto sulle rive scure del fiume Bruche, in Alsazia, territorio francese sotto occupazione nazista dal 1940. Il vento pungente che scendeva dalle montagne portava con sé non solo il freddo che bruciava la pelle, ma anche l’odore acre del fumo dei camini e l’odore metallico della paura.

Claire Duret, 29 anni, rimase in piedi durante l’appello mattutino. Le tremavano le mani, non solo per il freddo; riusciva a malapena a mantenere la posizione eretta. Le tremavano le gambe e ogni volta che cercava di spostare leggermente il peso, lo sentiva. Un dolore acuto, profondo, insopportabile, lo stesso dolore che tutti sembravano condividere, ma di cui nessuno osava parlare ad alta voce.

Accanto a lei, una donna sui quarant’anni con i capelli grigi emise un gemito soffocato. Una delle guardie si voltò immediatamente. “Silenzio!” urlò in tedesco. La donna si morse il labbro inferiore fino a farlo sanguinare. Claire strinse i pugni nelle tasche strappate della sua uniforme a righe. Conosceva quel dolore.

Tutti la conoscevano. Era il dolore che seguì quell’atto. L’atto che i soldati tedeschi imposero come punizione, come controllo, come un modo per spezzare la dignità di queste donne fino a lasciarle con nient’altro che cieca obbedienza. Claire era stata catturata tre mesi prima, nell’ottobre del 1943, in un convento benedettino vicino a Strasburgo.
Non era una suora; era una messaggera della Resistenza. Cuciti nella fodera del cappotto, portava con sé documenti criptati con informazioni sulle vie di fuga dei piloti alleati abbattuti in Francia. Quando i soldati della Gestapo fecero irruzione nel convento, Claire cercò di bruciare i documenti. Fallì.
La trascinarono fuori, la picchiarono davanti alle suore e la portarono a Shirmeek, un campo che ufficialmente non esisteva nei registri nazisti, ma che era ben noto alla Resistenza francese come il luogo da cui nessuno faceva ritorno. Shirmeek era diverso dai grandi campi di sterminio come Auschwitz o Dahao.
Non c’erano camere a gas, ma qualcosa di altrettanto devastante era in atto: torture psicologiche e fisiche metodiche e calcolate, applicate specificamente alle donne. Il campo ospitava circa 200 prigionieri: un’infermiera catturata, una spia, un messaggero della resistenza, un insegnante accusato di nascondere ebrei e un civile denunciato dai vicini collaborazionisti.
Condividevano tutti lo stesso destino: lavori forzati nelle vicine fabbriche di munizioni, interrogatori brutali e l’atto. L’atto era qualcosa che le guardie compivano con una frequenza quasi rituale. Non era uno stupro nel senso convenzionale del termine, sebbene anche quello accadesse. Era qualcosa di peggio, più umiliante, più distruttivo.
I soldati costringevano le prigioniere a sedersi su oggetti affilati, ruvidi e appuntiti. A volte si trattava di pezzi di legno con chiodi leggermente esposti, a volte di barre di metallo incandescenti. In altre occasioni, venivano semplicemente costrette a sedersi su superfici di cemento ghiacciato per ore durante gli interrogatori o ad assistere alle torture di altre donne.
L’obiettivo era chiaro: distruggere la dignità di queste donne, ridurle a semplici numeri, e funzionò. Molte prigioniere, dopo settimane di questo trattamento, riuscivano a malapena a camminare. Alcune svilupparono gravi infezioni, altre sanguinavano silenziosamente, nascondendo il dolore perché sapevano che ammettere la propria debolezza significava essere mandate in infermeria, da cui poche tornavano.
Claire non aveva ancora vissuto il peggio. Ma sapeva che era solo questione di tempo. Nei tre mesi trascorsi dalla sua cattura, era stata interrogata sei volte. Sempre la stessa domanda: chi è il capo della cellula di resistenza a Strasburgo? E sempre la stessa risposta: non lo so. Ma lei lo sapeva, lo sapeva benissimo.
Il leader era Étienne Duret, suo fratello minore. Étienne aveva solo 26 anni, ma era già responsabile del coordinamento delle vie di fuga, del sabotaggio delle linee ferroviarie utilizzate dai nazisti e della trasmissione clandestina di informazioni agli Alleati tramite radio.
Claire era stata arrestata mentre consegnava un messaggio a un contatto a Saverne. Se avesse parlato, Étienne sarebbe stato catturato, insieme a decine di altri combattenti della resistenza. Così Claire rimase in silenzio e ne pagò il prezzo. Quella mattina di gennaio, dopo l’appello, i prigionieri furono condotti in fila indiana al cortile di lavoro.
La neve accumulata scricchiolava sotto i piedi nudi di molti. Claire indossava stracci avvolti intorno ai piedi invece delle scarpe. Ogni passo che faceva era uno sforzo consapevole. Il dolore pulsava, acuto, costante. Fece un respiro profondo, cercando di mantenere un’espressione impassibile. Poi vide qualcosa che la fece fermare per una frazione di secondo.
In un angolo del cortile, vicino al capanno degli attrezzi, sedeva una giovane donna. Non poteva avere più di vent’anni, seduta sul terreno ghiacciato, con lo sguardo perso nei suoi pensieri. La sua uniforme era strappata sulle cosce. C’era del sangue. Claire riconobbe l’espressione sul suo viso. Era l’espressione di chi si era arreso.
“Avanti!” urlò una guardia, facendosi da parte dietro di lei. Inciampò, ma non cadde. Continuò ad avanzare, ma non riusciva a togliersi quell’immagine dalla testa. Quella donna era ciò che tutti rischiavano di diventare. E Claire giurò in quell’istante che non avrebbe permesso che le accadesse, non finché aveva ancora la forza di resistere.
Quella notte, dopo aver passato ore a caricare casse di munizioni in un magazzino gelido, Claire tornò nella baracca che condivideva con altre cinquanta donne. Non c’erano letti, solo assi di legno ricoperte di paglia umida. L’odore era insopportabile. Sudore, urina, malattie. Ma Claire ci si era abituata.
Strisciò fino al suo angolo in fondo alla baracca e si sdraiò su un fianco, evitando di esercitare pressione sulla zona che ancora gli bruciava per il dolore. Poi, con cautela, prese dalla fodera del pagliericcio un pezzetto di carta strappato da un sacco di cemento e un pezzo di carbone che aveva trovato vicino al forno.
E cominciò a scrivere nomi, date, brevi descrizioni. Tutto ciò che ricordava di ciò che aveva visto quel giorno. Era pericoloso. Se fosse stata scoperta, sarebbe stata giustiziata immediatamente. Ma Claire sentiva di doverlo fare, che un giorno qualcuno avrebbe dovuto sapere cosa era successo lì. Scrisse il 15 gennaio 1944.
Una giovane donna, con i capelli scuri e un’uniforme lacera, sedeva nel cortile intriso di sangue, con lo sguardo perso e il nome sconosciuto. Doveva avere vent’anni, forse meno. Poi rimise il giornale nella manica e chiuse gli occhi. Il dolore era ancora lì, ma anche la sua determinazione. Sarebbe sopravvissuta, a qualunque costo.